|
 |
Quivi se pone la forma dela prima maynera dela ballata piçola.
|
 |
|
|
|
|
Nel quinto libro di Dioscoride, tradotto e commentato da P.A.Mattioli nel 1568, ci viene data dimostrazione di come il vino, durante i secoli che ci hanno preceduto, sia stato utilizzato come medicamento. Considerato da Dioscoride finissimo "liquore, vero sostentamento della vita nostra, rigeneratore de gli spiriti, rallegratore del cuore, restauratore potentissimo di tutte le facultà, operationi corporali, però meritamente si chiama vite la pianta preziosissima, che lo produce. Ma non però per questo piglino ardire gli ebbriati, sentendomi cui tanto lodare il vino: percioche essendo ogni estremo (come si dice) vizioso, quando si bee oltre quello, che bisogna, causa (come poco qui sotto diremo) horrendi morbi. Et però dico, che bevuto moderatamente conferisce molto annutrimento del corpo, genera ottimo sangue, […] fa buono animo, rasserena l'intelletto, rallegra il cuore, vivifica gli spiriti, provoca l'orina, […] provoca l'appetito, chiarifica il sangue, […] e caccia fuori tutte le cose superflue. Ma bevuto senza modestia, senza regola (come fanno gli ebbriachi) infrigidisse tutto il corpo […].Nuoce al cervello, alla nuca, à i nervi: però causa […] mal caduco, spasimo, stupore, tremore, abbagliamento d'occhi, vertigini, […] letargia, […] tortura. Corrompe dopo questo i buoni, lodevoli costumi […]". |
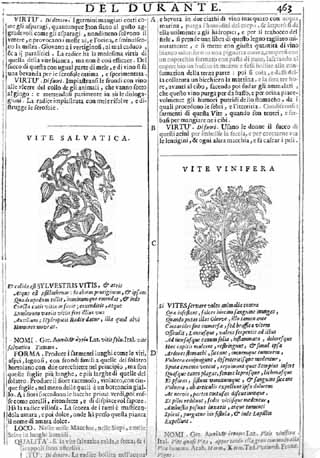 |
Inoltre Mattioli definisce questa bevanda con il meritato appellativo "Acqua di vita" attribuendole diverse capacità curative che influiscono positivamente su ogni membro del corpo soprattutto "beendosene ogni giorno un cucchiaro la mattina à digiuno".
Anche il medico Castore Durante nel suo "Herbario nuovo" del 1717 valuta le qualità mediche sia della "vite vinifera". Relativamente alla vite selvatica Durante afferma che la radice bollita nell'acqua e bevuta in due cucchiai di vino annacquato con l'acqua marina, purga l'umidità del corpo. Le donne usano il succo dei suoi acini per abbellire la faccia, cacciare via le lentiggini, e fare cadere i peli. Infine ci presenta la vite vinifera come giovamento alla dissenteria, agli stomaci deboli, agli appetiti corrotti delle donne gravide. Le fronde di questa vite mitigano inoltre i dolori del capo e, mescolate con la polenta, le infiammazioni dello stomaco, aggiungendo anche che il dentifricio prodotto con essa può portare il colore dei denti ad un bianco simile all'avorio.
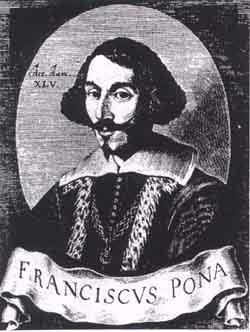 |
Anche Francesco Pona nel 1631 aveva descritto il vino come il più "communerato tra le medicine. Aureo,odorato, puro in minima quantità: Perch’egli à gran convenienza con gli spiriti, e la Pestilenza, à retta linea si mette à fronte alla Virtù Spirituale per atterrarla. A’ tumori, non doversi applicar materie molto attraenti, mà dolcemente disponesti la materia alla cottione". |
Nella sua "Opera Omnia", che fu pubblicata nel 1555, il Fracastoro incluse un piccolo trattato dal titolo "De vini temperatura sententia" nel 1534. Esso contiene un giudizio relativo ad una controversia che ebbe luogo fra due medici veronesi, Antonio Fumanelli e Bartolomeo Gaioni, che si erano affidati a lui per sapere se considerare il vino "caldo e umido", come lo riteneva Gaioni, oppure "caldo e secco" come lo riteneva il Fumanelli. A quel tempo erano presenti tali classificazioni conseguenti alle indicazioni ippocratiche. La caratterizzazione medica degli alimenti dalle differenti caratteristiche "umido, secco, caldo e freddo" era allora collegata ai presunti umori del corpo umano, dunque anche il vino, generalmente considerato "caldo e secco" poteva svolgere un'attività rilevante per il ripristino dell'equilibrio umorale alterato da qualche patologia. Il Fracastoro affermò che il vino è insieme caldo e secco quindi, dando ragione ad Antonio Fumanelli, non dimenticò di tenere conto delle diverse situazioni. Inoltre, pose in evidenza le proprietà del vino puro e la presenza nella composizione di questo di "particelle" calde e fredde. Probabilmente questa sua convinzione fu influenzata dal pensiero atomistico che lo portò anche a costruire la "teoria del contagio". |
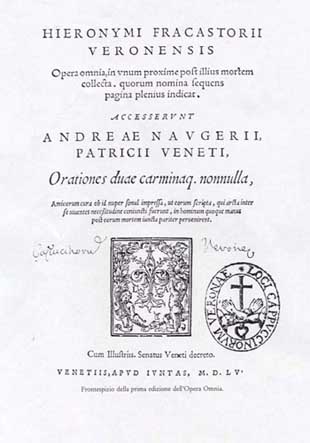 |