|
Fonti: -"La Gardesana del vino Bardolino", di Paronetto Lamberto, 1994 -"L'enotecnico", marzo 1995 |
1. Premessa
2. La vite nella storia
3. Il vino: Alimento o
"Venenum"?
4. Viti e qualità di
vino nelle fonti veronesi
5. Il ruolo di S.
Zeno e di Fracastoro nella storia del vino Bardolino
6. Tabella storiografica
|
Fonti: -"La Gardesana del vino Bardolino", di Paronetto Lamberto, 1994 -"L'enotecnico", marzo 1995 |
|
 |
IL RUOLO DI S. ZENO E DI FRACASTORO NELLA STORIA DEL VINO BARDOLINO
|
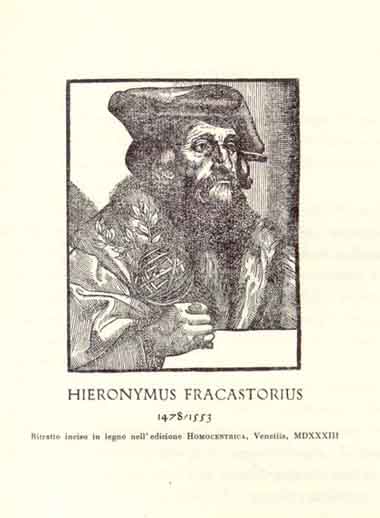 |
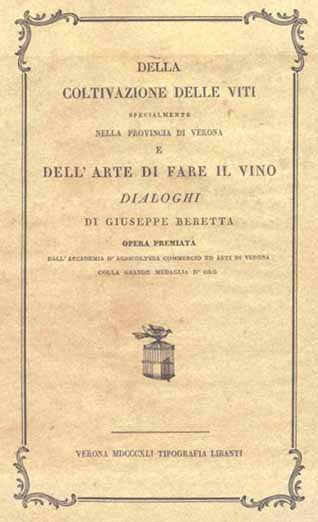 |
52 Milioni di anni fa…(epoca terziaria) | A
Bolca sono stati trovati reperti fossili di alcuni vitacee. |
| Periodo Neolitico | Nelle
stazioni di Poloda e Puegnano sono stati rinvenuti vinaccioli di Vitis silvestris;
nelle vicinanze di Peschiera e Solferino sono venuti alla luce vinaccioli di Vitis
vinifera silvestris. |
|
| 7°-6° sec. a.C. | Viene ritrovata a Valeggio una Situla, ossia un vaso sacrale per contenere il vino. |
|
| 1°sec. a.C. | Catullo, nelle sue liriche, dimostrò particolare attaccamento al vino retico. |
|
| 79 | Plinio parla del vino retico e della coltivazione della retica in "Veronesi agro" |
|
| 1° sec. d.C. | A San Giorgio in Salici vengono ritrovate anfore e Pàtere romane usate nei convivi. |
|
| 100 | Vino
"retico" dei Romani. |
|
| 386 | S. Zeno, vescovo di Verona, è diventato protettore del Bardolino perché nelle sue prediche teneva in grande considerazione le viti e i vignaioli. |
|
| 800 | Interesse dei grandi monasteri per la produzione del vino sul Garda, i monaci Colombani di Bobbio e di S. Giulia di Brescia si interessano alla coltivazione della vite nella zona Gardesana. |
|
| 930 | Presenza di alcune vigne nella località di Sanguinetto. |
|
| 1325 | Gidino da Sommacampagna, colto uomo di lettere che pone in rilievo i buoni e cattivi effetti del vino. |
|
| 1371 | La peste contagia il territorio veronese. |
|
| 1372 | L'amministrazione Scaligera subentra in alcuni centri abitati ( Valeggio, Custoza,…) per amministrare le fattorie. |
|
| 1492 | Scoperta dell'America importazioni in Europa di specie filossero-resistenti al fine di salvare i vigneti |
|
| 1500 | G.
Fracastoro parla di "retica vite" nei suoi scritti; A. Bacci ricorda il
vino retico dei Romani nel testo "De naturali vinorum historia" del 1595. |
|
| 1630 | Diffusione della peste nel territorio della Gardesana. |
|
| 1631 | F. Pona parla del vino come medicamento. |
|
| 1816 | Ciro Pollini scrive la poderosa opera "Flora Veronansis" descrivendo in modo dettagliato le varietà dei vitigni veronesi. |
|
| 1841 | G. Beretta pubblica un'opera relativa alla coltivazione della viti e all'arte di fare vino in Verona. |
|
| 1854 | Pasteur studia la fermentazione e i saccaromiceti. |
|
| 1860 | Viene trovato nella zolfatura delle viti il rimedio contro l'oidio. |
|
| 1897 | Solitro nell'opera "Benaco" riconosce un'esigenza di una personalizzazione del sapore dovuta a vitigni autoctoni quali Negrara, Corva, Rossera. |
|
| 1913 | La filossera colpisce le zone della provincia di Verona, si ricorre quindi ad un reimpianto dei vigneti su piede Americano. |
|
| 1937 | Nascita del consorzio per la difesa e la tutela dei vini pregiati Veronesi: Bardolino, Valpolicella, Soave. |
|
| 1968 | Disciplinare sul Bardolino |
|
| 1987 | Modifica della disciplinare stessa. |